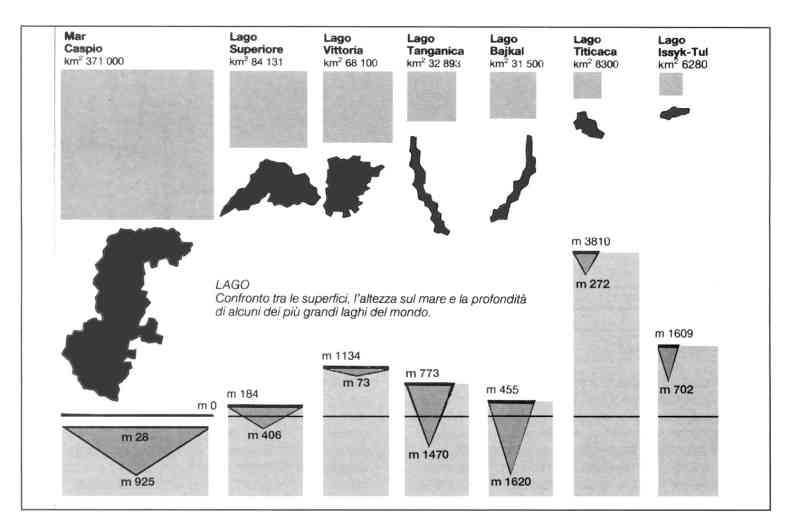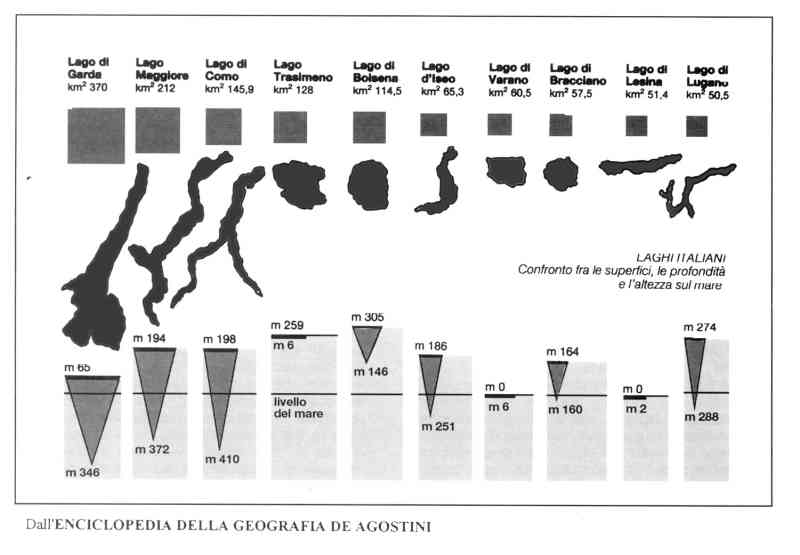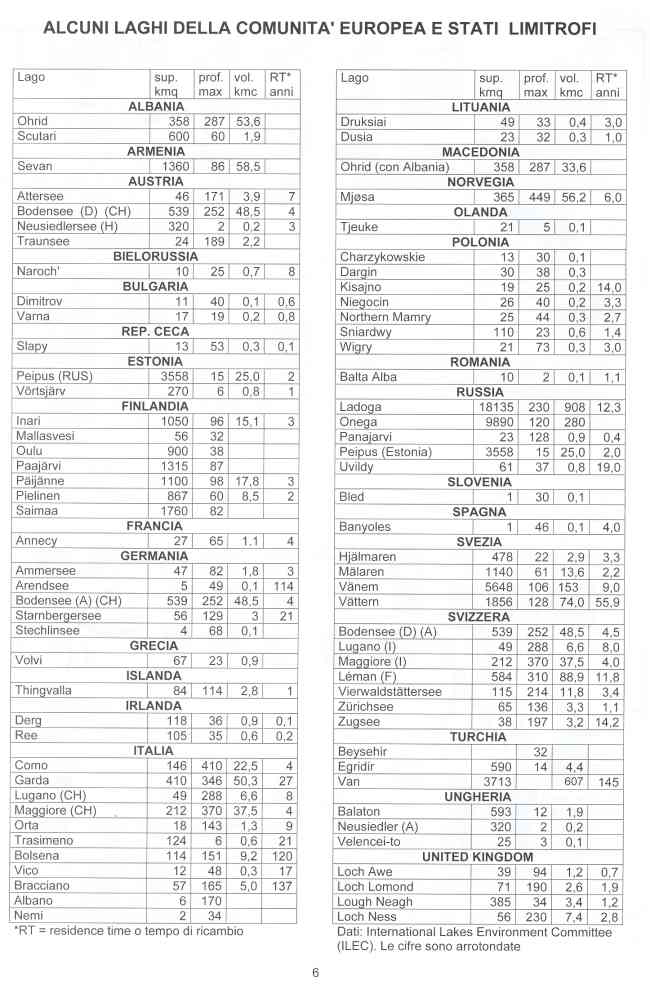I Laghi
Da
un punto di vista strettamente idrologico, i laghi sono masse d’acqua
raccolte in depressioni della superficie terrestre non alimentate dal
mare. La loro classificazione avviene generalmente sulla base di criteri
geologici, secondo l’origine della conca e del suo eventuale sbarramento.
Si hanno laghi di origine tettonica, vulcanica, glaciale, vallivi, di
sbarramento, carsici, di frana ecc.
Alcuni laghi hanno a monte grandiosi bacini di raccolta delle acque piovane,
per cui la portata dei loro emissari è copiosa. Altri invece hanno
bacini limitati e conseguentemente la portata dei loro emissari è
esigua. Ciò ha importanza per l'efficienza del ricambio dell'acqua.
La dimensione e la forma sono estremamente variabili, come si può
osservare nell’unita rappresentazione schematica. Altri fattori
di rilievo sono la natura delle rocce del bacino, la composizione chimica
dell’acqua, la struttura dell'ecosistema, ecc.
L'ubicazione geografica determina in buona parte il comportamento fisico
dei laghi: quelli del nord Europa durante l’inverno sono congelati
in superficie e non possono, in quel periodo, scambiare ossigeno con l’aria,
quelli tropicali hanno uno strato superficiale molto caldo che, galleggiando
sugli strati più profondi, ostacola il rimescolamento e l'ossigenazione
al fondo.
Nei laghi alpini i livelli d'acqua più alti si verificano nella
tarda primavera o in estate, quando si sciolgono le nevi, nell’Italia
centrale invece si verificano in inverno, quando abbonda la pioggia.
Vi sono conche formate da rocce impermeabili, che delimitano nettamente
il contorno del lago, altre invece, come quelle di origine vulcanica,
sono porose e permeabili per cui il lago può rappresentare la parte
affiorante di un acquifero di dimensioni superiori (Bolsena). In questi
casi sono frequenti entrate ed uscite sommerse di acqua.
La Regione Lazio ha un interessante campionario di laghi di origine vulcanica
(Mezzano, Bolsena, Vico, Monterosi, Bracciano, Martignano, Albano, Nemi),
molto caratteristici nel contesto europeo. Fra questi, nella Provincia
di Viterbo troviamo il lago di Vico la cui conca è una caldera,
il lago di Bolsena la cui conca è una depressione tettonica molto
complessa formata da più caldere, i laghi di Mezzano e Monterosi
le cui conche sono crateri esplosi.
La media delle precipitazioni che cadono annualmente sull'Italia è
di un metro e di uguale misura è l’evaporazione. Ciò
significa che le piogge che cadono direttamente sui nostri specchi
lacustri ripristinano mediamente solo le perdite per evaporazione. L’acqua
in eccesso, quella che defluisce dal fiume emissario, equivale grosso
modo all’apporto proveniente dal bacino, per cui, i laghi alimentati
da estesi bacini, come quelli alpini, hanno emissari di grande portata,
invece i laghi alimentati da piccoli bacini, come quelli di origine vulcanica,
hanno portate esigue.
Ad esempio, chi è stato a Zurigo ricorderà l’impressionante
dimensione dell’emissario Limat che attraversa la città.
Confrontando la sua portata con quella dell'emissario Marta del lago di
Bolsena (foto a pagina 23), si trarranno utili riflessioni sulla grande
diversità di comportamento fra laghi alpini e vulcanici.
La tabella che segue indica le principali caratteristiche idrologiche
dei maggiori laghi italiani. In essa RT indica il “tempo di ricambio”,
che è il numero di anni che impiegherebbe l’emissario per
far defluire un volume d’acqua pari al volume del lago. Le portate
dell'emissario ed i tempi di ricambio si riferiscono agli anni 60: non
sono più attuali a causa dei crescenti prelievi idrici a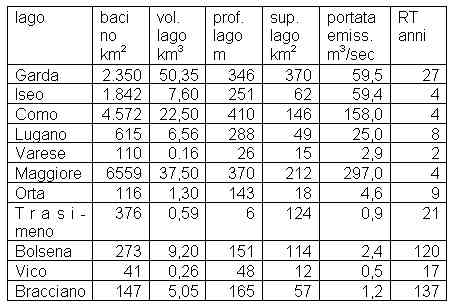 monte. Infatti, la portata del Marta, che era di 2,4 m3/sec alla fine
degli anni 60, è diminuita a meno di 1 m3/sec, per cui il tempo
di ricambio è aumentato a oltre 400 anni.
monte. Infatti, la portata del Marta, che era di 2,4 m3/sec alla fine
degli anni 60, è diminuita a meno di 1 m3/sec, per cui il tempo
di ricambio è aumentato a oltre 400 anni.
Il tempo di ricambio è un indice della capacità del lago
di smaltire attraverso l’emissario parte degli inquinanti che giungono
dal bacino, ma un ricambio rapido non garantisce da solo un buono stato
del lago. Com'è facile intuire, se il ricambio è effettuato
con acqua più pulita di quella del lago, il risultato è
vantaggioso, in caso contrario è dannoso.
Un esempio eclatante è dato dal lago giapponese Kasumigaura che,
malgrado abbia un tempo di ricambio rapidissimo, di soli 200 giorni, è
verde e maleodorante a causa del grave stato di eutrofia in cui si trova.
Ciò è dovuto all’acqua che lo alimenta, inquinata
dai fertilizzanti agricoli abbondantemente usati nelle circostanti risaie.
Altri laghi invece, il cui ricambio avviene con acqua pura, proveniente
ad esempio dallo scioglimento di neve e ghiacciai, non possono che trarre
vantaggio da un ricambio rapido.
Nelle pagine che seguono esamineremo singolarmente i diversi fattori che
intervengono nel bilancio idrologico del lago di Bolsena.